Sono cresciuta con mia nonna che mi diceva “a San Martino ogni mosto diventa vino”, e l’11 novembre era il giorno dedicato alle castagne e all’assaggio del vino che mio nonno faceva comprando le uve a Velletri.
Un vino che oggi chiameremo ‘naturale’ e che lui faceva seguendo le sue tradizioni venete riposandolo nella cantina che si era costruito, e dove si incontrava con i collaboratori al termine delle giornate lavorative.
Questi sono anche i giorni dell’estate di San Martino legati alla storia del vescovo francese che tagliò il suo mantello in due parti per proteggere un viandante. Poi incontrò un altro viandante e gli regalò anche la rimante parte del mantello così, commosso da tanta generosità, il Signore fece arrivare una temperatura mite: l’estate di San Martino.
San Martino era un punto di svolta e di termine del ciclo della terra: a novembre si assaggiava il vino, si seminavano i campi e poi ai contadini non restava altro che aspettare l’inizio di un nuovo anno lavorativo in primavera.
Diciamo che intorno all’ 11 novembre la fermentazione del mosto era completata e si poteva capire già il carattere del vino. Era il momento in cui si poteva scegliere se fargli fare un po’ di legno in botti o barrique oppure lasciarlo riposare in pace.
Quindi la tradizione italiana di San Martino è da sempre legata all’enologia. Eppure non siamo riusciti a creare un valore attorno al vino novello, come invece sono riusciti a fare i francesi. Ma cerchiamo di capire perché.
Il vino novello francese e quello italiano
Il disciplinare francese del Beaujolais nouveau è molto rigido al punto da riuscire nel tempo a creare attese e un’allure di fascino legato ad uno stile di vita originale. Infatti, la storia in Francia è iniziata nella zona del Beaujolais dove i viticoltori avevano creato questo particolare vino soltanto da uve Gamay, quelle meno pregiate rispetto a tutti gli altri loro vitigni.
Per legge, quindi, il vino novello è solo il Beaujolais nouveau da uve Gamay vinificate con macerazione carbonica, ossia con grappoli posti interi in contenitori stagni dove viene immessa anidride carbonica. Solo al termine di 10 giorni, i residui dei grappoli vengono pigiati e gli eventuali residui zuccherini si trasformano in alcol con una fermentazione tradizionale.
Il risultato è un vino fresco con poco tannino, pronto per essere degustato dopo appena trenta giorni con un rito che ha superato i confini della Francia raggiungendo ogni paese del mondo.

La parola novello indica quindi sia il vino appena prodotto, sia un vino leggero che deve essere consumato immediatamente perché non è adatto all’invecchiamento. Per questo viene immesso nel mercato il terzo giovedì di novembre, ritirato a fine dicembre e i suoi due mesi di presenza sono un vero evento.
Seguendo il successo francese, circa 30 anni fa gli italiani iniziarono una grande campagna di comunicazione rinnovando la tradizione di San Martino con il vino novello che doveva essere leggero ma con bouquet aromatico adatto ai cibi autunnali come funghi o caldarroste. Poi era una situazione ottimale perché coincideva con le tante sagre e feste delle castagne presenti in moltissime zone d’Italia.
Ma perché oggi non si sente più parlare di vino novello in Italia?
Non vorrei fare polemiche, ma noi italiani l' abbiamo ‘buttata in caciara’. Per legge abbiamo autorizzato la dizione ‘vino novello’ a un vino prodotto da circa 60 diversi vitigni e poi abbiamo autorizzato la miscela del vino novello prodotto da macerazione carbonica con altri vini disponibili in cantina. Praticamente solo il 40% del vino deve provenire dalla macerazione carbonica.
Questa facilitazione ha permesso a molti furbetti di utilizzare quello che avevano a disposizione. In pratica hanno rovinato tutto e il consumatore si è spesso ritrovato un vino non all’altezza delle aspettative. Siamo passati nel giro di pochi anni dai 17 milioni di bottiglie consumate ai circa 3 milioni.
Per questo oggi per assaggiare un vero vino novello bisogna andare direttamente da quei pochi produttori che lo producono mettendoci la loro faccia e dando garanzie di qualità.
Noi di Donna Vittori (www.donnavittori.com) comunque abbiamo approfittato della giornata per andare ad assaggiare il vino nuovo con il nostro enologo Gabriele Graia e siamo molto soddisfatti di Clea, Lazio Rosso IGT.
Non vi raccontiamo invece di Lettera, il Cesanese di Piglio DOCG perché con i problemi della peronospora la produzione 2023 sarà molto limitata e ce la gusteremo solo con gli amici.






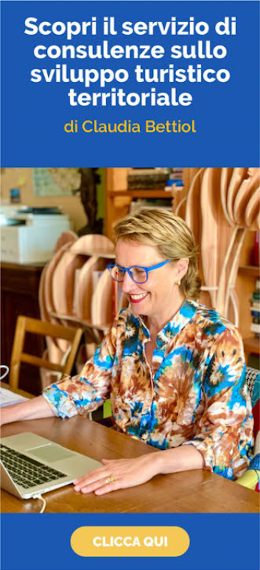

Seguici sui social