Qualche giorno fa ho postato la foto di un piatto particolare che stavo preparando. Mi piace farlo perché sono profondamente convinto che invadere il web di cose belle sia un modo per contrastare il nulla che dilaga, e cosa c’è di più bello, alto, culturale, interessante e scritto con un linguaggio universale, del cibo?
Quasi subito, un mio amico dal DNA 100% lombardo risponde al mio stato: “ti sei convertito alla polenta?” perché il piatto fotografato era una enorme polenta gialla versata su una spianatoia che evidentemente contrastava con le mie origini siciliane.
Rispondo: “Ci credi se ti dico che sto preparando una ricetta di mia nonna?”
Infatti, quella ricetta che stavo preparando con la polenta la ricavavo da ricordi di ragazzino in quel di Caculla, frazione Pioppo nel comune Monreale, provincia di Palermo, regione Sicilia.
È una storia tutta particolare anche perché quel piatto lo ho ricostruito sulla base di ricordi e nella pratica non lo avevo mai assaggiato, perché in effetti nessuno lo aveva mai cucinato in mia presenza.
Direte voi: “come fai a riscostruire sulla base di ricordi qualcosa che non hai conosciuto e quindi che in teoria non potresti ricordare?”
Il fatto è che i ricordi non erano i miei ma di mia nonna quando era ragazza. Dunque ho ricostruito il piatto sulla base di un ‘ricordo di un ricordo’. Una di quelle storie che catalogavo nella mia mente di bambino come “cose dei tempi antichi” e di cui ero particolarmente ghiotto. Mia nonna poi non era un tipo particolarmente loquace e forse anche grazie a questo mi è riuscito facile ritrovare nel mio “archivio” il “documento” che mi aveva consegnato, anche a distanza di moltissimi anni.
Il piatto è una sorta di lasagna di polenta che ho battezzato “Palenta ri ronna Giuvannina a strania” che in italiano potrebbe suonare come “Polenta di donna Giovannina la straniera” anche se in effetti non rende.

La storia inizia nel 1913 quando un giovane pioppese Giacomo Noto, viene richiamato per il servizio di leva che durava 2 anni. Nel 1915 era in procinto di congedarsi ma scoppia il finimondo che abbiamo studiato a scuola e viene spedito direttamente a combattere sulle sponde del Piave, dove, tra le splendide colline patrimonio dell’umanità tra Conegliano e Valdobbiadene, terra del prosecco, vive appunto la Giovannina.
Così il nostro caro Giacomo, che fu tra i pochi graziati usciti vivi dal tritacarne della grande guerra, nel 1920 quando fece ritorno a casa dopo la bellezza di 7-8 anni non fu da solo. E da Giacomo e Giovanna nacquero cinque bimbe e un maschietto, tra cui appunto mia nonna Celestina.
Nei ricordi di mia nonna, contadina per tutta la vita, il piatto nasceva sui campi dove il padre seminava il mais “che non era come il mais di ora ma erano cucciazza (letteralmente chicchiacci) grossi così” forse di qualche varietà usata nel trevigiano di cui avevano portato i semi.
Successivamente il compito dei bambini era di sgranarlo manualmente e poi occorreva attendere che il mugnaio facesse macinare il mais, quando puliva la macina dal frumento prima di passare alla macinazione dei ceci, visto che non era molto comune che qualcuno chiedesse di macinare il mais.
Quindi, per le feste importanti la madre preparava la polenta sia per la famiglia e sia, delivery ante litteram, per i militari della locale stazione dei Carabinieri che a detta di mia nonna erano polentoni come la Giovannina.
La preparava cuocendola su un calderone “per ore” e poi la gettava su uno scannaturi (spianatoia) per successivamente tagliarla a fette sottili con uno spago.
Le fette, poi, venivano adagiate su una teglia alternando strati di polenta con strati di sucu cu capuliatu e i piseddi, il tipico ragù siciliano con carne tritata e piselli che si mette per esempio nelle arancine.
Ricordo ancora il gesto di mia nonna con la mano che mimava lo spargere degli ingredienti nella teglia: i pezzi di caciotta fresca e tanto cascavaddu saliatu (caciocavallo grattugiato). All'occorrenza, se c’era, e spesso non c’era mai perché erano tempi di ristrettezze, anche salame o prosciutto.
Infine, si ricopriva di ragù, si dava un’altra spolverata di caciocavallo e si infornava e, come diceva mia nonna, “era meglio delle caramelle!”.





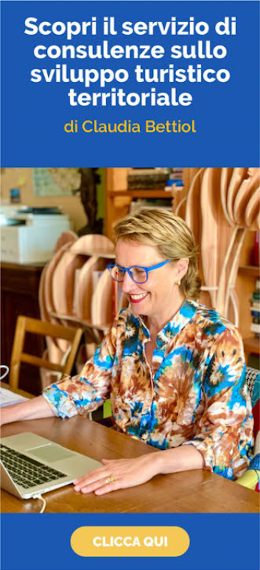

Seguici sui social